Un'altra triste pagina di storia.
Grazie per averla condivisa con noi.
Complimenti per il tuo "lavoretto"


Un'altra triste pagina di storia.
Grazie per averla condivisa con noi.
Complimenti per il tuo "lavoretto"
luciano
Un lavoro stupendo, complimenti! Aspetta che lo veda Alpino X!!!
Una triste storia. Interessante, proprio un bel lavoro.
Complimenti per il tema trattato e sopratutto per il lavoro di ricerca
Gianfranco
Gianfranco
molto interessante, grazie
.."Collezionare per me è un modo come un altro per sognare"... G.B.
Capitolo terzo
La rieducazione politica
1.L`organizzazione dell`attività* politica
L`attività* di propaganda era per l`Urss un elemento centrale del trattamento dei prigionieri nemici e aveva avuto origine nel periodo immediatamente successivo la Rivoluzione d`ottobre, quando venne fatta opera di propaganda tra i prigionieri tedeschi e austroungarici.
Il lavoro politico era gestito dal Comitato esecutivo del Komintern (Ikki), affiancato dal Purrka, la Direzione politica dell`Armata Rossa; a sostegno di quest`ultima, l`Ikki creò una speciale commissione per il lavoro politico tra i prigionieri, composta da Walter Ulbricht, Vincenzo Bianco, Zoltan Szanto e Johann Koplenig1.
La propaganda politica fra i prigionieri era affidata ai fuoriusciti politici appartenenti alle varie nazionalità*, sempre accompagnati da un commissario sovietico padrone della lingua.
I comunisti italiani che parteciparono a questa attività* furono alcune decine dei quali soltanto di alcuni si conoscono le generalità* complete2; di questi i più importanti furono Palmiro Togliatti (all`epoca segretario del Komintern), Vincenzo Bianco (responsabile dell`attività* di propaganda tra i prigionieri italiani), Edoardo D`Onofrio e Paolo Robotti.
Consci della tragedia che stavano vivendo i loro connazionali fatti prigionieri, i fuoriusciti italiani reagirono in modo differente come dimostra il rapporto epistolare svoltosi tra Bianco e Togliatti; così il primo scrisse al secondo:
Ti pongo una questione molto delicata di carattere politico molto grande. Penso che bisogna trovare una via, un mezzo per cercare, con le dovute forme, con il dovuto tatto politico, di porre il problema, affinché non abbia a registrarsi il caso che i prigionieri di guerra muoiano in massa come è già* avvenuto. Non mi dilungo, tu mi comprendi, perciò lascio a te di trovare la forma per farlo (...).3
Bianco chiedeva dunque un cambiamento nel trattamento dei prigionieri, appellandosi al segretario del Komintern; ma la risposta di questi, frutto della totale adesione di Togliatti al comunismo internazionale e della mancanza di reale influenza sul potere staliniano, fu la seguente:
L`altra questione sulla quale sono in disaccordo con te è quella del trattamento dei prigionieri. Non sono per niente feroce, come tu sai. Sono umanitario quanto te. O quanto può esserlo una dama della Croce Rossa. La nostra posizione di principio rispetto agli eserciti che hanno invaso l`Unione Sovietica, è stata definita da Stalin, e non vi è più niente da dire. Nella pratica, però, se un buon numero di prigionieri morirà* in conseguenza delle dure condizioni di fatto, non ci trovo assolutamente niente da dire. Anzi. E ti spiego il perché. Non c`è dubbio che il popolo italiano è stato avvelenato dalla ideologia imperialista e brigantesca del fascismo. Non nella stessa misura che il popolo tedesco, ma in misura considerevole. Il veleno è penetrato tra i contadini, tra gli operai, non parliamo della piccola borghesia e degli intellettuali, è penetrato nel popolo insomma. Il fatto che per migliaia e migliaia di famiglie la guerra di Mussolini, e soprattutto la spedizione contro la Russia, si concludano con una tragedia, con un lutto personale, è il migliore, è il più efficace degli antidoti (...). I massacri di Dogali e di Adua furono uno dei freni più potenti allo sviluppo dell`imperialismo italiano, e uno dei più potenti stimoli allo sviluppo del movimento socialista. Dobbiamo ottenere che la distruzione dell`armata italiana in Russia abbia la stessa funzione oggi (...).
T`ho già* detto: io non sostengo affatto che i prigionieri si debbano sopprimere, tanto più che possiamo servircene per ottenere certi risultati in un altro modo; ma nelle durezze oggettive che possono provocare la fine di molti di loro, non riesco a vedere altro che la concreta espressione di quella giustizia che il vecchio Hegel diceva essere immanente in tutta la storia.4
Togliatti si rifiutò quindi di prendere qualsiasi iniziativa a favore dei prigionieri italiani, considerando la morte di migliaia di essi "il più efficace degli antidoti" contro la politica fascista; si preoccupò, invece, affinché il lavoro politico fosse ben organizzato, così da poter guadagnare i prigionieri superstiti alla causa comunista.
Così Nikolaj Terescenko, maggiore dell`esercito sovietico e istruttore nelle scuole antifasciste, ricorda l`interessamento di Togliatti per il lavoro politico:
Il partito comunista italiano ritiene suo sacro dovere e suo compito nazionale andare in aiuto dei prigionieri. Vi posso dire che appena abbiamo saputo dell`arrivo dei prigionieri italiani nei campi, la direzione del partito ed io abbiamo subito preso misure per inviare ai campi dei comunisti capaci di svolgere il lavoro necessario tra i prigionieri. Diversi compagni da lungo tempo lavorano lì, ma tuttora continuiamo a radunare questi uomini.5
Coadiuvati dai commissari politici sovietici, i propagandisti italiani, indottrinati nelle scuole di partito sovietiche, si presentavano ai prigionieri italiani con descrizioni apologetiche del sistema sovietico, argomentazioni che troppo stridevano con la realtà* della prigionia e che ebbero ben poca presa tra i prigionieri. Così li ricorda un reduce:
In generale non si manifestò mai una decisa ostilità* contro i commissari politici: la loro casacca suscitava sempre una certa diffidenza, ma la presenza di un italiano tra i carcerieri destava sempre una certa speranza di appoggio presso le autorità* del campo. Tuttavia, fin dal primo momento, i fuoriusciti raramente risultarono all`altezza del loro compito, anche di fronte ai soldati, e si dimostrarono spesso incapaci a comprendere la psicologia dei prigionieri. La lunga lontananza dalla terra natale rendeva le loro semplicistiche argomentazioni terribilmente monotone e ridicole così che spesso essi destavano un senso di commiserazione misto a disprezzo.6
1M.T. Giusti, "I prigionieri...", p.112
2L. Vaglica., "I prigionieri...", p.85
3La lettera di Bianco a Togliatti fu pubblicata da "Panorama" il 9.2.1992
4La lettera, pubblicata per la prima volta su "La stampa" il 15.2.1992, è riportata in M.T. Giusti, "I prigionieri...",p.55
5Nicolaj Terescenko, "L`uomo che torturò i prigionieri italiani",Milano, Vangelista, 1994, p.109
6Valdo Zilli, "Fascisti ed antifascisti in Russia", in "Il Ponte", anno 6 , n.11, Novembre 1950, pp.1369-1370
Nella vita sangue e conoscenza debbono coincidere.Allora sorge lo Spirito.
2.Strategie e obiettivi della propaganda
La propaganda si sviluppò con strategie e fini in relazione a obiettivi a breve e a lungo termine; nel periodo antecedente l`armistizio dell`8 settembre 1943, l`instabilità* e le difficoltà* della situazione bellica indirizzarono la propaganda nel coinvolgimento dei prigionieri alla diserzione delle truppe al fronte e alla rottura dell`alleanza italo-tedesca.
Così è scritto nel Programma delle iniziative della squadra dei compagni Terescenko e Edo7:
Il compito del movimento (...) è quello di creare una piattaforma politica che orienti la massa fondamentale dei prigionieri contro la partecipazione dell`Italia alla guerra e a favore della coalizione democratica. A tale scopo gli slogan politici principali della propaganda saranno:
1. uscita dell`Italia dalla guerra contro la coalizione anglo-sovietico-americana.
2. rottura dell`alleanza tra l`Italia e la Germania, che costringe l`Italia a proseguire la guerra contro l`Inghilterra, gli Stati Uniti e l`Unione Sovietica.
Il rovesciamento del governo di Mussolini deve essere il terzo obiettivo e deve fondarsi sulla considerazione che, per colpa di Mussolini, è iniziata la guerra che non sembra volgere al termine e che qualunque governo italiano, veramente nazionale e non di tipo fascista, che si dovesse formare ora in Italia, porrebbe fine alla guerra contro i paesi democratici e si sgancerebbe immediatamente dall`alleanza con la Germania, un`alleanza mortale per il popolo italiano.8
I prigionieri coinvolti in queste operazioni propagandistiche, venivano direttamente inviati al fronte e, muniti di megafoni e ricetrasmittenti, invitavano alla resa i propri connazionali; in questa direzione era la diffusione di volantini, firmati da soldati caduti prigionieri, sulla linea del fronte.
I volantini potevano avere temi diversi, quali la solidarietà* tra lavoratori, la falsità* della propaganda fascista o la mancanza di affinità* tra il popolo italiano e quello tedesco come dimostrano i seguenti esempi:
Stiamo partendo per andare a lavorare e faticheremo in mezzo a coloro che sono lavoratori e contadini come noi. Ci hanno detto che i russi torturano e fucilano: è una menzogna. E attraverso simili menzogne ci hanno ingannato e ci hanno condotto come si fa con il bestiame (...)9.
Perché vi scriviamo questa lettera? Perché noi non possiamo permettere che voi nostri compatrioti continuate a combattere contro i russi invincibili (cosa già* nota a tutti) per gli interessi e i vantaggi dei banditi di Hitler che a noi sono completamente estranei10.
Come obiettivo a lungo termine, gli istruttori politici si proponevano di indottrinare i prigionieri così da poter avere elementi influenti sulla vita politica italiana, completamente cambiata dopo la caduta del fascismo e l`armistizio con gli Alleati.
La partecipazione dei prigionieri nel nuovo scenario politico italiano iniziava sin dai campi, ove venivano registrati messaggi radiofonici ( che potevano essere sottoscritti o meno dai prigionieri) inerenti le vicissitudini della patria lontana e trasmessi in Italia tramite Radio Mosca; l`importanza della comunicazione radiofonica fu subita colta dai sovietici, i quali crearono stazioni radio in tutto il territorio europeo.
Talvolta, la sottoscrizione dei messaggi veniva sfruttata dai prigionieri come mezzo per far sapere alla famiglia di essere ancora vivi, più che per convinzioni politiche11, data, come si è visto, l`impossibilità* di scrivere a casa.
Vi furono poi proposte di rientro anticipato in Italia, se disposti ad operare come una quinta colonna; così un reduce ricorda la proposta fattagli da un tenente dell`NKVD:
La nostra proposta è questa: tu sei radiotecnico e radiotelegrafista, ti diamo in dotazione una ricetrasmittente, i codici e contatti con cui dovrai operare; ci invierai notizie sulle forze americane, tedesche e fasciste, sarai protetto e pagato bene. Sbarcherai subito a Bari.12
7Squadra formata quindi da Nicolaj Terescenko e da Edoardo D`Onofrio.
8M.T. Giusti, "I prigionieri...", p.113
9Volantino firmato F. Severino e P. Marlini, Ivi,p.114
10Ivi
11L. Vaglica, "I prigionieri...", p.80
12L. Venturini, "La fame dei vinti", p.128
Nella vita sangue e conoscenza debbono coincidere.Allora sorge lo Spirito.
3.Il lavoro politico "di massa"
La rieducazione politica nei campi si sviluppò lungo due direttive: la prima era rivolta alla massa dei prigionieri delle diverse nazionalità*; la seconda, non accessibile a tutti, consisteva nella frequentazione delle scuole antifasciste, ove poter approfondire le tematiche proposte dai propagandisti.
Il lavoro politico di massa, oltre che diffondere su larga scala i principi dell`antifascismo, doveva servire all`individuazione dei soggetti maggiormente inclini alla propaganda e quindi meritevoli di frequentare le scuole antifasciste13.
Esso si serviva di diversi strumenti: gli interrogatori, le assemblee di prigionieri suddivisi per nazionalità*, la creazione di gruppi antifascisti all`interno del campo, la creazione di giornali murali,la collaborazione al giornale "L`Alba".14
L`interrogatorio aveva la funzione di accertare le tendenze politiche del prigioniero e toccava gli aspetti più diversi: dai dati anagrafici del prigioniero alle notizie riguardanti la famiglia e il lavoro, dalle domande di carattere militare a quelle sulla fede politica; spesso l`interrogatorio metteva in luce le grandi differenze di vita e di cultura tra Italia e Urss. Questo il ricordo dell`interrogatorio da parte di due reduci:
-Dove abiti?
-A Roma.
-In famiglia?
-Si, con i genitori ed un fratello.
-Chi altri abita con voi?
-Come chi altri?
-Le altre famiglie.
-Ma noi abitiamo soli!
-Avete un appartamento tutto per voi?
-Si,tutto per noi, tre stanze, cucina e bagno.
-Allora tuo padre è un capitalista.
-Macchè capitalista! à? un impiegato delle poste e la casa l`abbiamo in affitto.
-Allora è un gerarca fascista.15
Ci chiedevano come fosse possibile che noi semplici cittadini possedessimo una casa o anche dei terreni. A tutte queste domande, cercavo di rispondere con immensa pazienza dicendo che in Italia ciò era assolutamente normale poiché era pienamente riconosciuto ai singoli individui il diritto di proprietà* e di libero scambio di beni, servizi e così via. Nonostante però la fatica dispiegata, si cozzava contro un muro e non mancavano al riguardo di catalogarci come fascisti e capitalisti.16
Agli interrogatori individuali seguivano le conferenze, le quali, organizzate per nazionalità*, avevano per tema l`andamento della guerra, l`antifascismo e l`esaltazione del sistema sovietico.
Alla conferenza seguiva il dibattito, al quale i prigionieri erano invitati a partecipare, allo scopo di individuare quelli più vicini alle idee antifasciste così come quelli più ostinati e avversi ad esse.
Contro questi ultimi gli istruttori si accanivano in particolar modo, in quanto se fossero riusciti a convincerli, sarebbe stata un`azione di indubbio effetto propagandistico, mentre se i prigionieri fossero rimasti nelle loro posizioni, dovevano essere allontanati, in quanto di ostacolo all`indottrinamento degli altri prigionieri17.
All`interno dei campi i commissari politici e i fuoriusciti organizzarono, tra i prigionieri della stessa nazionalità*, i gruppi antifascisti, costituiti da antifascisti di ogni tendenza politica e, quindi, non necessariamente comunisti.
Questi gruppi erano divisi in un "attivo allargato" e in un "attivo ristretto"; il primo era composto dai prigionieri che partecipavano alle assemblee e alle altre attività* antifasciste mentre l`"attivo ristretto" era composto da elementi scelti, licenziati dalle scuole antifasciste, con il compito di intervenire nei comizi e nelle conferenze, di redigere relazioni sull`andamento della propaganda e di riferire agli istruttori politici il comportamento dei prigionieri18.
Questi gruppi furono naturalmente aiutati dall`evolversi della situazione politica italiana: la caduta del fascismo, l`armistizio e la dichiarazione di guerra alla Germania resero i prigionieri più disponibili a collaborare con i propagandisti.
A titolo d`esempio si prenda l`ordine del giorno proposto dal gruppo antifascista del campo di Oranki il 3 agosto `43, sottoscritto da 217 ufficiali su 270; prima del 25 luglio solo una quarantina di ufficiali si erano pronunciati contro la guerra e a favore della lotta contro il fascismo19.
Ad integrare il lavoro dei propagandisti concorrevano la redazione di giornali murali e la lettura di libri, disponibili in molti campi; così il reduce Carlo Vicentini ricorda la biblioteca del campo di Suzdal:
Il campo fu sommerso da decine di esemplari di libri di Marx, di Lenin, di Stalin, in edizione italiana, rilegati; non mancavano per i più evoluti, stralci dell`opera di Hegel. Facevano parte della collezione, la storia del partito comunista bolscevico, la collettivizzazione, lo stacanovismo, le realizzazioni ottenute dai piani quinquennali. Non era una lettura entusiasmante, ma a quel tempo, era l`unica possibilità* che avevamo, di mettere gli occhi su della carta stampata.20
In alcuni campi i libri erano acquistabili, elencati, con i relativi prezzi, nelle pagine de "L`alba"; ecco quelli presenti nel n°36:
Mario Correnti21, "Discorsi agli italiani", 8 rubli; Massimo Gorki, "La madre", 13 rubli; Carlo Marx, "Scritti scelti", 10 rubli; Alessandro Serafimovic, "Il torrente di ferro", 5 rubli; M.Ercoli, "L`Italia in guerra contro la Germania hitleriana";Eugenio Varga, "Il fallimento della mobilitazione totale in Germania", 40k.22
13M.T. Giusti, "I prigionieri...", p.119
14L. Vaglica, "I prigionieri...",p.107
15C. Vicentini, "Noi soli vivi", p.222
16V. Di Michele, "Io, prigioniero in Russia",p.120
17L. Vaglica, "I prigionieri...", pp.110-112
18Ivi,p.116
19M.T. Giusti, "I prigionieri...", p.124
20C. Vicentini, "Noi soli vivi", p.218
21Mario Correnti era lo pseudonimo di Palmiro Togliatti.
22"L`Alba", n.36, 14 dicembre 1943, in L. Vaglica, "I prigionieri...", p.114
Nella vita sangue e conoscenza debbono coincidere.Allora sorge lo Spirito.
4.Le scuole antifasciste
La frequentazione delle scuole antifasciste era prevista solo per i prigionieri più meritevoli, dimostratisi affidabili e attivi nella propaganda; erano comunque presenti dei criteri di scelta per la tipologia di prigionieri a cui prestare più attenzione:
ï?· transfughi e prigionieri di guerra che si sono consegnati spontaneamente;
ï?· ex membri del partito comunista o delle organizzazioni giovanili comuniste, oppure ex funzionari delle organizzazioni rivoluzionarie di massa, affidabili;
ï?· parte di ex partigiani socialdemocratici, di appartenenti ad organizzazioni cattoliche;
ï?· prigionieri di guerra che nei punti di accoglienza e nei campi di smistamento si sono dichiarati attivi oppositori al regime fascista;
ï?· prigionieri di guerra capaci, che prima lavoravano in grosse aziende, che possono fornire notizie preziose di carattere politico (...) sui fatti che possono essere usati nel nostro lavoro di propaganda nei paesi che combattono contro di noi;
ï?· contadini capaci; rappresentanti dell`intelligencija;
ï?· nella stessa direzione va condotto il lavoro tra gli ufficiali, una certa parte dei quali può essere vicina a noi.23
Le scuole antifasciste atte a ricevere i potenziali candidati furono due: quella di Juza e quella di Krasnogorsk; la prima iniziò le proprie attività nell`agosto 1943 mentre la seconda, situata a una decina di chilometri da Mosca, entrò in funzione nell`autunno dello stesso anno.24
La differenza tra le due scuole la indica il maggiore Terescenko, insegnante nella scuola di Krasnogorsk, nelle sue memorie:
Se la scuola di Juza continuava a funzionare come, per così dire, scuola elementare, che forniva ai prigionieri conoscenze semplici ed essenziali sulla storia del paese dei soviet, nonché sulla storia d`Italia e del fascismo; alla scuola di Krasnogorsk furono assegnati compiti più ampi. Essa doveva non solo approfondire lo studio delle nozioni che gli studenti avevano già appreso alla scuola di Juza, ma , a differenza di essa, doveva fondamentalmente insegnare ad essi discipline complesse come l`economia politica marxista, il materialismo dialettico e il materialismo storico.25
In sostanza, la scuola di Krasnogorsk era una scuola di perfezionamento per gli studenti più meritevoli dell`altro istituto.
Le scuole erano suddivise in settori determinati dalla nazionalità dei prigionieri; a Krasnogorsk il settore italiano era diretto da Terescenko, quello di Juza da Scevljagin. Inoltre a Krasnogorsk, assieme ad altri quattro collaboratori, lavoravano Paolo Robotti (alias Robotti Pavel Petrovic) e Matteo Giovanni (alias Ivan Regent).26
Tutti percepivano una retribuzione che variava dai 1200-1400 rubli degli insegnanti ai 500-700 rubli dei collaboratori come segretari e traduttori.27
Gli allievi più meritevoli, una volta licenziati dalle scuole, andavano a far parte dell`"attivo ristretto" dei gruppi antifascisti, affiancando gli istruttori nell`opera di propaganda.
Ma non tutti i frequentatori delle scuole soddisfacevano gli insegnanti:
Tra i primi due contingenti di studenti-volontari erano non pochi quanti dagli orrori della guerra da essi sofferti non potevano o non volevano trarre nessuna lezione di vita. Erano uomini legati senza soluzione di continuità all`immagine abituale del loro capo fascista, il duce Mussolini, e ai suoi slogan: "credere,obbedire,combattere". Tra questa categoria di prigionieri c`erano anche coloro che, pur essendo coscienti dell`avventurismo del regime fascista, restavano non di meno suoi sostenitori, perché in questo regime essi e i loro congiunti avevano prosperato materialmente e avevano raggiunto un`elevata posizione sociale. Indossata la falsa maschera di "antifascisti", i prigionieri di questa categoria filofascista venivano a scuola coscientemente non solo per avere informazioni sulla sua attività e sul comportamento degli autentici antifascisti, ma anche per tentare di disorganizzare il lavoro della scuola, paralizzare la sua influenza culturale sugli studenti28.
Oltre a questi "provocatori", c`era chi frequentava le scuole solo per godere del trattamento migliore riservato ai corsisti; ma anche la frequentazione delle scuole dovette fare i conti con la disorganizzazione del sistema sovietico e con la cronica mancanza di cibo tanto da suscitare le proteste di Walter Ulbricht, leader comunista tedesco coordinatore del lavoro politico tra gli internati suoi connazionali, che evidenziò alla direzione della scuola come:
1. gli uditori ricevono come prima le vecchie norme. Se tali norme non verranno aumentate ciò potrebbe portare a pesanti conseguenze per la loro salute. Qualche giorno fa è morto uno di loro.
2. tutti gli uditori indossano cenci. Nei lager non vi sono indumenti migliori.29
Il numero di prigionieri italiani che frequentarono le scuole antifasciste è incerto; nelle sue memorie Terescenko ha scritto:
Se parliamo del numero complessivo dei soldati e degli ufficiali italiani che hanno seguito i corsi di studio alla scuola di Krasnogorsk, esso può sembrare molto modesto. In tutto, dal dicembre 1943 all`estate 1945, la Scuola licenziò circa 500-550 studenti, dei quali circa 100-120 nei miei gruppi. à? certamente molto poco. Tuttavia, se anche solo la metà di essi è divenuta un testimone sincero della verità sul paese dei Soviet e sulla guerra, un attivo contrappeso rispetto a quanti diffondevano le idee fasciste e la demoralizzazione nei campi di prigionia, allora questo è già un risultato importante.30
Nell`archivio statale militare russo, come riportato nel saggio della Giusti, è invece scritto che furono 395 i prigionieri che frequentarono la scuola di Krasnogorsk e 548 quella di Juza31; nell`archivio dell`ufficio storico dello stato maggiore dell`esercito (AUSSME) è invece presente il risultato di un`inchiesta svolta a rimpatrio avvenuto che, in base alle dichiarazioni degli ufficiali prigionieri, indica in 77 il numero di ufficiali che frequentarono la scuola di Krasnogorsk.32
23Progetto. Ai responsabili dei punti di accoglienza e dei campi di smistamento dei prigionieri di guerra, in M.T. Giusti, "I prigionieri...", p.127
24Ivi,p.131
25N. Terescenko, "L`uomo che torturò...", p.133
26M.T. Giusti, "I prigionieri...", p.132
27Ibidem
28N. Terescenko, "L`uomo che torturò...", p.138
29M.T. Giusti, "I prigionieri...", p.84
30N. Terescenko, "L`uomo che torturò...", p.142
31M.T. Giusti, "I prigionieri...", p.135
32Ivi,p.303
Nella vita sangue e conoscenza debbono coincidere.Allora sorge lo Spirito.
5. "L`Alba"
Il 10 febbraio 1943 uscì il primo numero de "L`Alba. Per un`Italia libera ed indipendente"; la diffusione dei giornali all`interno dei campi era uno dei mezzi propagandistici messi in atto dall`organizzazione sovietica per diffondere il credo comunista e, oltre al giornale italiano, uscì quello per i prigionieri tedeschi, "Freies Deutschland", e quello per i romeni, "El graiul liber".33
Così, nel primo numero de "L`Alba", viene spiegata la scelta del titolo:
L`alba della nuova Italia già* appare fra i lutti, i tormenti ed il sangue del popolo italiano; si diffonda e si ravvivi la luce di questa alba nei campi dei prigionieri di guerra dell`URSS.34
Allo stesso modo, veniva spiegato il sottotitolo "Per un`Italia libera ed indipendente":
Il popolo italiano cesserà* la guerra, scaccerà* i tedeschi e rifarà* l`Italia nuova, libera ed indipendente, sentendosi così riaccendersi nel suo petto i grandi ideali di Mazzini e Garibaldi.35
Per la cronica mancanza di carta, le dimensioni del giornale erano abbastanza ridotte: il formato era di 26x39 cm, quattro pagine su quattro colonne; dal numero 5 del 4 aprile 1943, il formato si ingrandì (34x51 cm), mantenendo le quattro pagine ma portando a cinque le colonne.36
La tiratura iniziale fu di circa 5000 copie, ma raggiunse anche quota 7000, un numero molto elevato in relazione ai potenziali lettori.37
Dopo i primi quattro numeri sotto la direzione di Rita Montagnana, moglie di Palmiro Togliatti, il giornale fu poi diretto fino all`agosto 1944 da Edoardo D`Onofrio,infine da Luigi Amadesi e Paolo Robotti; del comitato di redazione facevano parte Vincenzo Bianco e Nicolaj Terescenko.38
La struttura delle quattro pagine del giornale era la seguente: la prima pagina era solitamente dedicata alle notizie derivanti dal fronte e all`esaltazione delle vittorie dell`Armata Rossa; la seconda conteneva articoli di elogio della vita e del sistema sovietico; nella terza si incontravano le notizie provenienti dai campi dei prigionieri di guerra, scritte dagli stessi internati e riguardanti la loro vita nei campi; l`ultima pagina conteneva articoli che criticavano il fascismo e notizie riguardanti l`Italia.39
Inizialmente, il giornale conteneva solo gli articoli scritti dai commissari sovietici e dagli esuli italiani,e riscosse ben poco interesse da parte dei prigionieri; per questo motivo venne stimolata la collaborazione da parte di questi ultimi, così da rendere "L`Alba" il giornale "dei prigionieri" e non "per i prigionieri".
Ciò avvenne dal numero 7 dell`8 maggio `43, dove, in terza pagina, assieme all`articolo collaboriamo volentieri erano elencati i nominativi di coloro disposti a collaborare col giornale40; nel corso del `43 le firme dei prigionieri su "L`Alba" furono 595, nel 1944 2039 e nel `45, causa l`inizio del rimpatrio, 592.41
Di tutti firmatari, solo una parte però erano produttori di articoli; i più si limitavano a mettere il proprio nominativo negli elenchi di sottoscrittori gli appelli.
La collaborazione richiesta ai prigionieri riguardava l`invio di articoli inerenti i soliti temi, quali l`antifascismo e l`esaltazione del sistema sovietico, ma anche la descrizione della vita nei campi, così raccontata da alcuni prigionieri:
Molti soldati in Italia non stanno così bene come noi,in questo bellissimo bosco di pini con un trattamento davvero eccezionale per un prigioniero. (...) In quale caserma italiana, anche in periodo normale, viene distribuita una razione di burro, lardo e zucchero giornaliera, tre abbondanti ranci ed altri viveri di conforto?42
La voce della baracca che canta,ci mostra lo stato d`animo dei camerati che, passato il momento d`incertezza dei primi mesi di prigionia, gustano ora le comodità* create per noi dal governo del popolo russo. (...) Rispondiamo alle amorevoli cure delle autorità* astenendoci dal sollevare lamentele assurde (...) La figura immobile della sentinella pare essere là*, non per controllare i nostri movimenti, ma per proteggere e difendere dall`alto della garitta, il nostro sonno.43
Simili falsità* non potevano che urtare la sensibilità* dei prigionieri, le cui sofferenze quotidiane troppo stridevano con gli idilliaci racconti che apparivano su "L`Alba", aumentando la loro diffidenza nei confronti del giornale:
Non abbiamo la minima idea di quanto stia succedendo in Italia. Non crediamo a quanto racconta il giornale e non sappiamo cosa pensare.44
Noi non vedevamo l`ora di avere il giornale, per dividerlo in dieci parti uguali, ricavandone cartine per sigarette, o per commerciare con i fumatori in cambio di cibo, per noi l`ascolto o la lettura di certe notizie anche importanti non avevano penetrazione, la parte scritta sfuggiva alla memoria, perché pensavamo solo alle cose da mettere sotto i denti.45
"L`Alba" concluse le sue pubblicazioni il 15 maggio 1946, dopo 144 numeri.46
33A. Petacco, "L`armata scomparsa",p.104
34"L`Alba", n.1, 10 febbraio 1943
35Ibidem
36L. Vaglica, "I prigionieri...", p.176
37N. Terescenko, "L`uomo che torturò...", pp.100-101
38L. Vaglica, "I prigionieri...", p.178
39Ivi, pp.179-180
40"L`Alba",n.7, 8 maggio 1943
41L. Vaglica, "I prigionieri...", p.195
42"L`Alba",n.16,27 luglio 1943, artigliere Angelo Colombo
43Ibidem,n.19, 17 agosto 1943, sergente maggiore Caovilla
44testimonianza del soldato semplice Giuseppe Dutto, in N. Revelli, "La strada del Davai", p.107
45Settimo Malisardi, "Presente alle bandiere", Bologna, APE, 1976, p.171
46L. Vaglica, "I prigionieri...", p.177
Nella vita sangue e conoscenza debbono coincidere.Allora sorge lo Spirito.

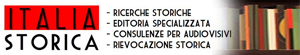 
|
 
|
 
|