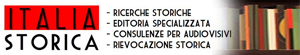-
Collaboratore

Una ciociara e la morte della Patria
Il concetto storico di “morte della patria” è entrato a far parte dell’ immaginario comune solo da una trentina d’ anni grazie alla generazione di studiosi revisionisti che iniziarono la lenta e difficile opera di sgretolamento della vulgata imposta per decenni dal potere agli Italiani. Ma già in questo testo degli anni ‘60, forse ispirato a un evento realmente accaduto o forse mero esercizio di retorica, l’ ex- corrispondente di guerra della R. M. Vero Roberti , che nel ‘44/’45 risalì combattendo la penisola inquadrato nel San Marco cobelligerante, mette in luce il sentimento di profonda diffidenza e disillusione del popolo dopo l’ 8 settembre e le catastrofiche conseguenze dell’ armistizio sulla vita di milioni di esseri umani. Gli italiani, saggiamente ispirati dal si salvi chi può della classe dirigente monarco-badogliana “trasferitasi in un altro punto del territorio nazionale” abbandonando a sé stessi esercito e popolo, scelsero da allora di privilegiare la sopravvivenza e il benessere dei propri nuclei familiari ad ogni costo e prima di ogni altra considerazione. Questo momento traumatico ha -per così dire - forgiato un italiano nuovo e deteriore, quello che tutti conosciamo dal secondo dopoguerra. Le conseguenze nefaste della riduzione della “Patria” a “paese” non smettono di far danni all’ Italia anche nel presente a tutti i livelli, basta aprire un giornale.
Ma torniamo al testo, un dialogo svoltosi secondo l’ autore nel 1944 con una illetterata contadina ciociara, incapace di scrivere al figlio - prigioniero in India - la definitiva morte di tutte le speranze e le illusioni di un popolo. Alla fine nella sua ingenuità è la stessa anziana donna a comprendere l’ incomprensibile e a dire l’ indicibile. La Vittoria è morta! La Patria è morta! Lo Stato è morto! E anche le RR. Poste non devono sentirsi troppo bene, se la postina di Veroli da mesi non fa più il suo giro.
Da: Vero Roberti - Con la pelle appesa a un chiodo - Mursia, 1966. Pagg. 145-146
Durante la guerra di Liberazione - ero sempre con la Marina - incontrai sulle montagne della Ciociaria una donna che si tolse dal busto alcune lettere e me le porse dicendomi: << Leggile, per piacere, tu che sei istruito! >>. Le lessi. Erano di suo figlio Righetto che era stato fatto prigioniero poco dopo l’ inizio della guerra; venivano dall’ India. << Leggi, leggi! >> instette la donna. << Vedrai che in ogni lettera mi chiede come sta la zia Vittoria, ma io non ho né una sorella né una cognata che si chiami Vittoria. Vittoria non è un nome ciociaro. Don Angelo, il nostro parroco, mi disse che doveva trattarsi della nostra vittoria, della vittoria dell’ Italia, e mi fece sempre scrivere che la zia Vittoria stava male, sempre male. Solo una volta mi disse di scrivere che la zia Vittoria stava un pochino meglio, era l’ estate del 1942. Don Angelo mi spiegò che i nostri poveri soldati, che facevano la guerra nel deserto dove non nasce neppure un filo d’ erba, avevano preso una città che si chiama Tobrucca. Oggi, però, mi sembra che la zia Vittoria sia proprio morta e non so cosa scrivere al mio Righetto. Se tu sapessi quanto mi dispiaccia dovergli dire che è morta! Che vuoi farci? Contro la morte non si può combattere, eppoi son già due mesi che la postina di Veroli non viene a ritirare le lettere. E tu che mi dici? >>.
Leggendo queste righe viene da tremare pendando cosa mai dovremmo rispondere se oggi il “marò Righetto” ci chiedesse notizie della salute di “zia Italia”.
Tag per questa discussione
 Permessi di scrittura
Permessi di scrittura
- Tu non puoi inviare nuove discussioni
- Tu non puoi inviare risposte
- Tu non puoi inviare allegati
- Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
-
Regolamento del forum



 Rispondi citando
Rispondi citando